I dilemmi delle macro-regioni
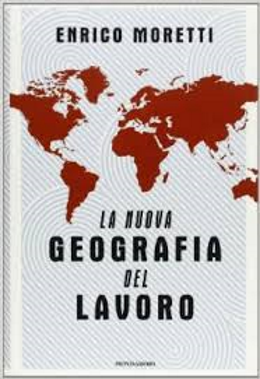
Torniamo a parlare in questi giorni di macroregioni, nell’ambito di quel ritorno quasi ciclico al passato che caratterizza da decenni il nostro dibattito sulle istituzioni. Basterà, in proposito, far cenno (ma mi limito davvero all’essenziale) al progetto della Fondazione Agnelli, vedi Un federalismo dei valori, a cura di Marcello Pacini, Torino, Fondazione Agnelli, 1996) e all’ipotesi di aggregazione formulata nel 1990-94 da Gianfranco Miglio.
Certo, rispetto al passato, interviene adesso un elemento nuovo: la geografia amministrativa italiana, anche in ragione del riassetto che l’economia globale impone nel cuore della crisi attuale, appare oggi particolarmente obsoleta.
Lo era, a ben vedere, sin dall’inizio dell’esperienza unitaria però. Ricordo solo che nella fase costituente dell’Italia unita i progetti regionalisti (Minghetti ecc.) furono subito sconfitti. L’impianto del nuovo Stato si basò piuttosto, nel 1861-65, su comuni e province, restando le regioni fuori gioco, una pura “espressione geografica”. Il disegno (rimasto solo sulla carta) delle regioni “storiche” ricalcò astrattamente modelli antichi: addirittura quello delle legioni romane, secondo alcuni; per essere poi ripreso dai primi statistici italiani in occasione dei censimenti. Per inciso, l’individuazione delle varie ripartizioni amministrative si ispirò in origine a due criteri contrastanti: da un lato alla “filosofia” dominante dell’uniformità amministrativa, di derivazione francese (Roberto Ruffilli nel suo studio dei primi anni Settanta su La questione regionale individuò felicemente come ciò corrispondesse all’opinione diffusa che quel modello, sostituendo i particolarismi dell’Ancien Régime, corrispondesse meglio alla “modernità”); dall’altro – e contraddittoriamente – alla persistenza di un ritaglio amministrativo che era lo stesso consolidatosi nell’Ancien Régime. Sicché all’atto pratico le partizioni (per esempio i confini tra le province) apparirono ispirate, piuttosto che all’ésprit geometrique napoleonico, ad un evidente rispetto di antiche solidarietà tra territori.
Tale rimase la situazione sino alla Costituzione. Quando finalmente, apparvero concretamente sulla scena le Regioni (dopo l’anticipazione delle speciali, oltre vent’anni dopo la previsione costituzionale, con il varo tardivo delle ordinarie) non vi fu, né in Parlamento né altrove, un serio dibattito sulla complessiva geografia amministrativa del Paese. L’antica carta geografica virtuale delle regioni italiane (quella appesa in ogni aula delle scuole elementari italiane sin dall’unità) corrispose più o meno alla mappa dei nuovi enti creati adesso dal legislatore. Quella trama (con successivi, pochi, adeguamenti) è la stessa oggi oggetto di valutazione critica.
Non c’è dubbio che questo disegno “storico” appaia oggi obsoleto, per almeno due buone ragioni:
a) Per gli effetti stessi prodotti dallo sviluppo economico, che ha “riscritto” i caratteri e le vocazioni naturali dei territori, ne ha allungato o accorciato la reciproca prossimità. Lucio Gambi ha anni fa insegnato quanto radicale sia stato spesso questa riscrittura, per cui la nuova mappa economico-sociale che ne deriva a stento collima con l’antica mappa amministrativa.
b) Per l’espandersi sul territorio di nuove, intensificate, reti di comunicazione, che riducono la distanza, consentono scambi più rapidi, modificano la demografia stessa con evidenti conseguenze sul piano della mobilità degli individui. Un primo esempio, puntualmente registrato all’epoca dai più acuti osservatori, si ebbe con il dipanarsi nella prima metà del Novecento della rete ferroviaria nazionale, e poi con quella autostradale, nel secondo dopoguerra. L’avvento oggi dell’informatica e delle reti virtuali accentua il fenomeno e impone una rivalutazione dell’intero problema centro-periferia.
Aggiungo che non tutte le Regioni godono della stesso grado di legittimazione esterna e persino della stessa autolegittimazione. Alcune (in primo luogo le speciali) sono state storicamente attraversate da un più forte senso autoidentitario, che trova ancora oggi radici nella geografia, nella storia, nella cultura, nella stessa situazione economica; altre comunità regionali guardano invece all’istituto-Regione caricandolo di minore enfasi simbolica, lo vivono piuttosto come una articolazione amministrativa che non come un riferimento identitario (non è da sottovalutare come la tradizione italiana sia spesso stata più municipalistica che non regionalistica).
Che fare, dunque? Un fattore nuovo, sinora insufficientemente presente nel dibattito, riguarda innanzitutto l’Europa: se si immagina un processo di integrazione europeo in progresso, si dovrà anche tener conto di come le macro-aree saranno organizzate su scala continentale. Occorrerà dunque una valutazione preliminare degli assetti degli altri paesi, nell’intento (sia pure con specificità che si radicano nelle varie tradizioni nazionali e nella diversità dei casi) di scegliere per l’Italia soluzioni il meno dissonanti possibile.
Di qui due conclusioni (provvisorie):
1) la prima di esse verte sulla necessità di rinunciare alla camicia di forza della uniformità amministrativa: certamente quanto a dimensioni (in fondo nel più importante ordinamento federale del mondo, gli Sati Uniti, coesistono piccolissimi e grandi Stati); forse però anche quanto a materie attribuite (meno invece – ma si può ragionarci – quanto ad ordinamento interno). Non è scritto in nessun libro sacro che nel tempo che viviamo (il tempo delle reti veloci e della frammentazione della domanda sociale) le istituzioni debbano disporsi sul territorio secondo criteri rigidamente uniformi e fare esattamente le stesse cose. Un sistema a dimensioni e attribuzioni variabili sembra invece più adatto a interpretare la fase attuale.
2) la seconda conclusione riguarda il “come” procedere. Si prospettano, stando anche a ciò che si percepisce in sede governativa, due possibili strade, forse non necessariamente del tutto reciprocamente alternative.
Una prima – più radicale – si identifica nella revisione dell’attuale ritaglio regionale, con accorpamenti e eventualmente riscrittura dei confini. In Parlamento la proposta di legge Morassut indica ad esempio questa soluzione. Ove si realizzasse essa dovrebbe stabilire la dimensione ottimale delle macroregioni che ne conseguirebbero (adottando criteri solo di densità demografica? Siamo sicuri che siano i più funzionali allo scopo?) e probabilmente affrontare un complesso riordino sulla base delle attuali vocazioni dei territori subregionali: distanze in termini di comunicazione, caratteristiche delle economie locali, effetti della mobilità delle popolazioni, incidenza di poli attrattivi centrifughi come ad esempio (per gli studenti) le università ecc.
Una seconda strada, meno radicale e certamente di minor impatto traumatico, è quella degli accordi anche eventualmente obbligatori, delle intese tra regioni, delle unificazioni anche solo parziali (per singoli settori) ecc. In vista dell’adozione di soluzioni modulari, anche diverse l’una dall’altra, nel rispetto delle asimmetrie presenti nella realtà e dei bisogni reali dei cittadini.
Su questa alternativa lavora da qualche settimana una commissione di studiosi ed esperti nominata presso il Ministero degli affari regionali.
Difficile trarre auspici o previsioni sul futuro delle regioni. Più facile forse concludere queste note con una considerazione che apparirà (e in effetti vuol essere) problematica.
Per molti versi il mondo contemporaneo è dominato da due fenomeni apparentemente contrastanti: da una parte il prodursi di asimmetrie tra territori e talvolta tra singole parte di essi. Asimmetrie dipendenti dallo sviluppo stesso dell’economia globale: insegna molto, ad esempio, la repentina modifica della geografia economica di un Paese come gli Stati Uniti di recente richiamata in un bel libro di Enrico Moretti (La nuova geografia del lavoro, Milano, Mondadori, 2013), con il declino di aree geografiche un tempo leader e l’avvento di nuove concentrazioni situate in zone storicamente considerate depresse; dall’altra l’estensione del sistema delle reti, in primo luogo di quelle universali della comunicazione istantanea, nel cui ambito le antiche gerarchie tra centri e periferie del mondo tendono a perdere di rilevanza, mentre conta sempre di più l’articolarsi delle interrelazioni nella rete tra soggetti spesso molto diversi l’uno dall’altro, anche per collocazione geografica.
Viene da domandarsi se, in un simile scenario caratterizzato da un estremo dinamismo, il futuro delle istituzioni potrà ancora fondarsi sulla uniformità e rigidità amministrativa (regioni eguali in ogni parte del Paese, leggi identiche per tutte le regioni) o non potrà e dovrà invece articolarsi su soluzioni organizzative differenti, ognuna calibrata sulle esigenze diverse della società di riferimento. Forme flessibili, istituzioni leggere, aggregazioni a seconda della reale esigenza che proviene dalla realtà, istituzioni fatte per i cittadini insomma, non sopra di loro.
* Professore ordinario di Storia delle Istituzioni Politiche, Università Roma-La Sapienza
di Paolo Pombeni
di Miriam Rossi *
di Guido Melis *


